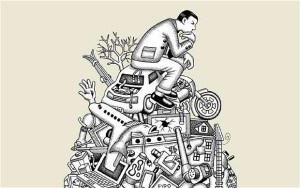Fare chiarezza su ciò che non esiste: l’ideologia gender. E’ uno degli obiettivi, anche se paradossale, del nuovo libro di Michela Marzano “Papà, mamma e gender” (UTET).
“Nel momento in cui non si accetta la possibilità di una parola che sia Altra, se non si fa spazio in sé all’alterità, non esiste nemmeno la possibilità dell’ascolto, senza il quale non si genera il dialogo. Condizione per iniziare a comunicare e capirsi è l’ascolto e le argomentazioni non hanno genere femminile o maschile. Sono logiche, giuste, corrette oppure non lo sono”. A sostenerlo è la filosofa e parlamentare del PD, professoressa ordinaria di filosofia morale all’Université Paris Descartes, invitata da Arcigay di Trento il 12 dicembre scorso in una affollata sala 3 del Centro servizi culturali Santa Chiara, per tentare di fare chiarezza sul “mare magnum” di imprecisioni e superficialità che circolano attorno al termine gender, alla cosiddetta ideologia gender, alla differenza di genere e all’educazione sessuale nelle scuole. “Non ho scritto rivolgendomi agli “antigender”, ma a tutti coloro che sentono il bisogno di capire meglio. Forse l’ho pubblicato troppo tardi: tra genitori e famiglie ormai si è diffusa la paura di un tentativo di chissà quale gruppo intento a distruggere i valori tradizionali e l’idea di famiglia”. Le argomentazioni dunque devono essere rigorose: occorre essere chiari nella terminologia e non disorientare come tendenzialmente fanno coloro che paventano l’esistenza di una “ideologia gender”. Confondono differenza di genere, ruolo di genere, orientamento sessuale, pratiche sessuali, differenza di sesso e identità di genere. “Ho sentito alcuni utilizzare il termine genere, affermando che ne esisterebbero tre tipi: omosessualità, transessualità e pedofilia. Da qui nascono le incomprensioni, i fraintendimenti”. Secondo la Marzano da tali ambiguità terminologiche nasce la malcelata tendenza a generare confusione per indurre paura e smarrimento tra chi deve approcciarsi a questi temi. “La pedofilia è un reato – detto in maniera chiara – non un genere”.
Provando a fare il punto. Esistono solo tre orientamenti sessuali: eterosessuale, omosessuale e transessuale. Non lo si sceglie e non è possibile cambiare orientamento sessuale o educare qualcuno a cambiarlo (tranquilli i genitori impauriti dalla possibilità che a scuola il proprio figlio cambi orientamento a causa di qualche lezione di educazione sessuale): “E’ un sentimento precoce, profondo e duraturo: non una scelta libera”. Altra questione è il genere: “Esiste una molteplicità di studi sul genere, ma nessuno mai ha messo in dubbio che esista la differenza di sesso: uomo e donna. Ma ci sono modi diversi d’essere donna ed essere uomo. Talvolta non ci si percepisce in armonia con il proprio corpo e in questo caso si parla di transessualità: ma sono una minoranza”. Esempio: “L’orientamento sessuale non ha nessun impatto sull’identità e viceversa: ci siamo sentiti ripetere per tantissimo tempo che una ragazza è necessariamente attirata da un ragazzo. Ma una ragazza che non viene attirata da un ragazzo, ma da una ragazza allora non è più una donna? Essere donna significa necessariamente essere attirati da un uomo? No: una donna può restare tale ed essere attirata da altre donne. Si è utilizzato per anni l’orientamento sessuale come costitutivo dell’identità di genere, mentre in realtà l’identità di genere è indipendente dall’orientamento sessuale”.
Marzano ha ricordato come sia importante essere precisi quando si parla di questi temi: occorre ricordarsi che dietro ci sono persone, a volte molta sofferenza, dolore. E non è un caso che il numero di suicidi in passato e ancora oggi sia alto tra persone omo e transessuali. Vittime di un clima culturale. Qualcuno ancora pensa che l’omosessualità sia una scelta: è un atteggiamento devastante contro chi vive questa condizione.
“Sono eterosessuale e cattolica – ha proclamato la Marzano – per anni ho atteso il principe azzurro della mia vita poi mi sono accorta che non dovevo attendermi dalle persone che amavo il riempimento di quel senso di vuoto che ognuno di noi si porta dentro per sempre. Con Camille Claudel ho realizzato che: “c’è sempre qualcosa di assente che mi perseguita”. Fa parte della nostra condizione umana”. La sua cattolicità l’ha dichiarata nell’incipit del libro con un accenno a Carlo Maria Martini, che nel suo ritiro gerosolimitano dopo aver lasciato Milano, incontrò il fratello della Marzano, omosessuale in cerca di pace per i suoi sensi di colpa indotti da una cultura ancora incapace di accogliere la sua differenza.
Per finire la scuola: “Deve essere in grado di generare spirito critico: dare strumenti. Sopratutto deve insegnare che bambini e bambine sono uguali. Universalità dell’uguaglianza nonostante le differenze. La famiglia delega alla scuola l’educazione dei propri figli: non decide sui contenuti. Oggi molti insegnanti sono terrorizzati dal parlare di queste tematiche come l’uguaglianza tra bambine e bambini perché hanno paura di genitori che li possono accusare d’essere seguaci del gender”. Per tutti quei genitori che invece volessero capire e non giudicare a pancia o condannare, ora c’è anche il libro della Marzano da poter leggere. Su tutto ciò incombe quello che i sociologi chiamano “knowledge gap”, il divario conoscitivo: chi è già informato e tende ad approfondire senza giudicare superficialmente non ha bisogno di questo libro. Gli altri continueranno a spaventarsi guardando qualche talk show televisivo o leggendo un messaggio “terroristico” sullo smartphone che minaccia la fine della famiglia tradizionale e l’arrivo dei fantomatici “mostri gender”.
(Articolo pubblicato su L’Adige il 15 dicembre 2015)