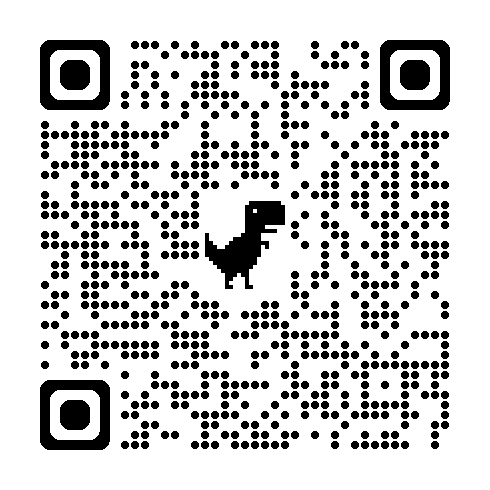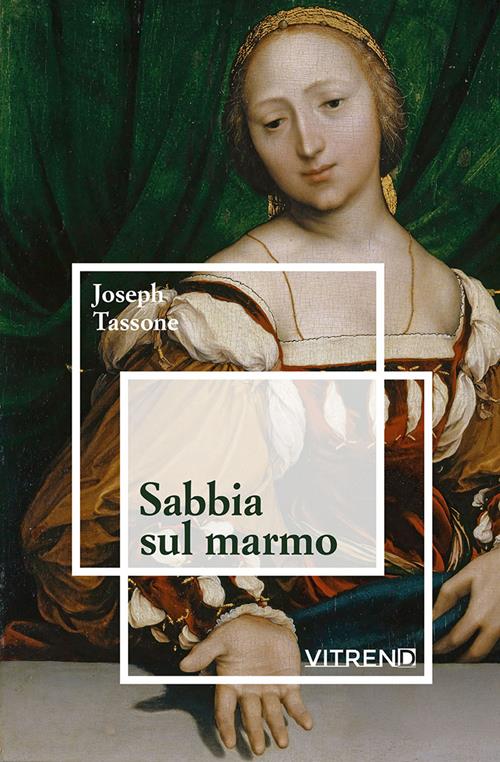Università della Terza Età e del Tempo Disponibile
La Libertà
Un percorso di “liberazione” attraverso la filosofia
Il Tema del Corso
Il concetto di libertà è centrale nella filosofia occidentale, ma il suo significato non è affatto scontato.
Questo percorso esplora la libertà non come uno stato dato, ma come un processo: un faticoso cammino di “liberazione”.
Ogni filosofo ci indicherà una “prigione” da cui fuggire e una “via” da percorrere.
Prima Lezione
Le Fondamenta della Libertà:
Dall’Anima alla Natura, da Dio all’Infinito
1. Socrate: La Prigione dell’Ignoranza
Il nostro viaggio inizia con una ridefinizione dell’essere umano. Per Socrate, “noi siamo la nostra anima”. L’identità risiede nella *psyché*, intesa come sede della vita intellettuale e morale.
La vera prigione, quindi, non è il corpo, ma l’ignoranza: l’agire senza conoscere il vero Bene.
“Nessuno compie il male volontariamente, ma per ignoranza.”
Socrate: La Liberazione attraverso la Conoscenza
Il percorso di liberazione è il celebre motto: “Conosci te stesso” (Gnōthi seauton).
La libertà si ottiene attraverso la “cura dell’anima”: un dialogo incessante (la maieutica) per liberare la nostra anima dalle false opinioni.
Concetto Chiave: Intellettualismo EticoLa vera libertà non consiste nel fare ciò che ci pare (schiavitù delle passioni), ma nell’agire secondo ragione, conoscendo il Bene.
2. Aristotele: La Libertà nell’Azione Concreta
Con Aristotele, la ricerca della libertà scende dal cielo alla terra. L’etica non è una scienza teoretica, ma una “scienza pratica”.
Il suo fine non è la conoscenza astratta del Bene (come in Platone), ma la felicità (*Eudaimonia*) raggiungibile in questa vita.
Importante: per Aristotele, l’uomo è libero. In campo etico e morale, le sue azioni non sono “necessarie” o preordinate.
Aristotele: La Prigione degli Estremi
La prigione da cui liberarci è il caos degli impulsi, il dominio delle passioni che ci spingono verso i due estremi: l’eccesso e il difetto.
Siamo schiavi quando siamo vili (difetto di coraggio) o quando siamo temerari (eccesso di coraggio).
Aristotele: La Liberazione come “Giusto Mezzo”
La libertà è autodeterminazione. Si realizza attraverso l’esercizio della virtù.
La virtù è la capacità, forgiata con l’abitudine, di scegliere il “giusto mezzo” tra i due estremi.
Strumento: La Saggezza (Phronesis)Il giusto mezzo non è una media matematica, ma una scelta che si adatta alla situazione. Per trovarlo serve la saggezza pratica, la virtù dianoetica che guida le virtù etiche.
3. Epicuro: La Prigione della Paura
Con l’ellenismo, la libertà si ritira dalla vita pubblica e diventa una conquista interiore. La prigione è il turbamento (*tarassia*) dell’anima.
Siamo schiavi di due paure fondamentali:
- La paura degli dèi (che ci puniscano).
- La paura della morte (che sia dolorosa o una fine terribile).
Epicuro: La Liberazione come “Atarassia”
Il percorso di liberazione è il “Quadrifarmaco”, una “medicina” per l’anima.
“Il male, la morte, non è nulla per noi: quando ci siamo noi, non c’è la morte; quando c’è la morte, non ci siamo noi.”
Concetto Chiave: AtarassiaLa vera libertà è l’assenza di turbamento. È la pace dell’anima che si raggiunge “vivendo nascosti”, liberandoci dai desideri superflui e dalle paure infondate.
4. San Tommaso: Il Rischio del “Liberum Arbitrium”
Nel pensiero cristiano, la libertà è un dono divino fondamentale: il libero arbitrio (*liberum arbitrium*), la facoltà di scegliere.
Questa stessa facoltà è però un rischio. La prigione è il peccato: l’uso errato della nostra libertà, la scelta del male.
La liberazione, quindi, è il percorso della Grazia e della Fede che “curano” la nostra volontà e la ri-orientano verso il Bene (Dio), che è il nostro fine ultimo.
5. Giordano Bruno: La Liberazione dal Dogma
Alle soglie della modernità, la prigione torna ad essere esterna: è il dogma.
Sono le catene imposte dalla tradizione, dalla filosofia aristotelica e dall’autorità religiosa che ingabbiano il pensiero in un cosmo finito e gerarchico.
La liberazione è la scoperta dell’universo infinito. L’anima umana, scintilla di questo infinito, ha un desiderio infinito di conoscenza.
Concetto Chiave: Eroico FuroreÈ lo slancio intellettuale e passionale che spinge l’uomo a superare ogni limite per unirsi con l’infinito. La libertà di pensiero è un valore assoluto, da difendere fino al rogo.
Fine della Prima Lezione
Riepilogo: Dalla conoscenza di sé (Socrate) e la virtù pratica (Aristotele), alla pace interiore (Epicuro), fino all’adesione al divino (Tommaso) e alla rottura eroica dei limiti (Bruno).
Seconda Lezione
Il Labirinto della Libertà Moderna:
Autonomia, Volontà, Esistenza
La Svolta Moderna: Le Prigioni Interiori
Con la modernità, il campo di battaglia della libertà si sposta all’interno dell’individuo.
Le catene non sono più (o non solo) il cosmo, Dio o la paura della morte. Le prigioni più difficili da espugnare sono dentro di noi: le nostre passioni, la nostra ragione, la nostra stessa volontà.
6. Kant: La Prigione dell'”Eteronomia”
Per l’Illuminismo kantiano, la prigione è l’eteronomia (da *heteros*, “altro”, e *nomos*, “legge”).
Siamo schiavi ogni volta che lasciamo che la nostra legge morale ci venga dettata da qualcosa di esterno a noi:
- Dalle nostre passioni (“faccio così perché mi piace”).
- Dall’autorità (“faccio così perché lo dice il Re / il Prete”).
- Dalla tradizione (“faccio così perché si è sempre fatto così”).
Kant: La Liberazione come “Autonomia”
Il percorso di liberazione è il motto stesso dell’Illuminismo:
“Sapere Aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza!”
La libertà è Autonomia (da *autos*, “se stesso”, e *nomos*, “legge”). È la capacità della ragione di dare legge a se stessa.
Kant: La Libertà è Obbedire alla Ragione
Siamo veramente liberi solo quando agiamo moralmente, cioè quando la nostra volontà sceglie di obbedire alla legge morale che la nostra stessa ragione scopre dentro di noi.
Questa legge è l’Imperativo Categorico.
Per Kant, la libertà non è fare ciò che ci piace, ma fare ciò che dobbiamo, scegliendo razionalmente di farlo.
7. Schopenhauer: La Prigione della Volontà
Dopo Kant, il pensiero romantico e idealista rovescia la prospettiva. Per Schopenhauer, la ragione è solo un’illusione.
La vera prigione è la realtà stessa. Il mondo è dominato da una forza cieca, irrazionale ed eterna: la Volontà di Vivere.
Noi non siamo liberi. Siamo solo marionette di questa Volontà che ci costringe a desiderare, lottare e soffrire, in un ciclo infinito e senza senso.
Schopenhauer: La Liberazione DALLA Volontà
Se la vita è prigionia e sofferenza, la liberazione non può essere *nella* vita, ma *dalla* vita.
Il percorso di liberazione ha tre tappe:
- L’Arte (una liberazione temporanea, contempliamo le idee senza desiderio).
- La Pietà (com-patire il dolore altrui).
- L’Ascesi (la liberazione definitiva).
Concetto Chiave: NoluntasLa vera libertà è la Noluntas: la negazione della volontà stessa, lo spegnimento del desiderio, il raggiungimento del Nirvana.
8. Nietzsche: La Prigione della “Morale degli Schiavi”
Nietzsche accetta la premessa di Schopenhauer (il mondo è caos irrazionale) ma ne rovescia la conclusione. La sua è una filosofia del “Sì” alla vita.
L’annuncio “Dio è morto!” non è una tragedia, ma una liberazione.
La vera prigione è la morale giudaico-cristiana: una “morale degli schiavi” nata dal *ressentiment* (risentimento) dei deboli, che ha definito “peccato” tutto ciò che è forte, nobile e vitale.
Nietzsche: La Liberazione come “Volontà di Potenza”
Il percorso di liberazione passa per il rifiuto dei vecchi valori e la creazione di nuovi. È il passaggio dall’uomo all’Oltreuomo (*Übermensch*).
La libertà non è negare la volontà (Schopenhauer), ma potenziarla.
Concetto Chiave: Volontà di PotenzaNon è il desiderio di dominare gli altri, ma la volontà di auto-superamento, di imporre la propria volontà creatrice sul caos e di diventare ciò che si è.
Nietzsche: L’Accettazione Totale (“Amor Fati”)
Il test supremo della liberazione nietzschiana è l’accettazione dell’Eterno Ritorno dell’Uguale.
Saresti libero e felice di rivivere questa stessa vita, con i suoi dolori e le sue gioie, infinite volte?
L’Oltreuomo è colui che risponde “Sì!” e pratica l’Amor Fati: l’amore per il proprio destino, qualunque esso sia.
9. Sigmund Freud: La Terza Rivoluzione
Il ‘900 si apre con una nuova, profonda messa in discussione della libertà.
Dopo Copernico (non siamo al centro dell’universo) e Darwin (siamo animali), Freud compie la terza “rivoluzione” o “umiliazione” per l’uomo.
“L’Io non è padrone in casa propria.”
La nostra libertà cosciente è un’illusione.
Freud: La Prigione dell’Inconscio
La nostra mente è un campo di battaglia. La nostra apparente libertà è in realtà determinata da forze che non controlliamo.
Siamo prigionieri di un conflitto tra:
- Es (Id): Le pulsioni biologiche, l’istinto, il principio di piacere.
- Super-Io (Super-Ego): La morale interiorizzata, il genitore, il giudice, il senso di colpa.
- Realtà Esterna: I vincoli del mondo.
L’Io (Ego) è il povero mediatore che cerca di non impazzire.
Freud: “Il Disagio della Civiltà”
Anche la società è una prigione. Per vivere insieme (la Civiltà o *Kultur*), dobbiamo reprimere le nostre pulsioni (sesso e aggressività).
Abbiamo scambiato la nostra felicità (libertà pulsionale) con la sicurezza.
“Il prezzo del progresso si paga con la riduzione della felicità, dovuta all’intensificarsi del senso di colpa.”
Freud: La Liberazione come Consapevolezza
La liberazione freudiana non è una libertà assoluta (impossibile), ma un faticoso aumento di consapevolezza.
Il percorso è la psicoanalisi: portare alla luce i traumi, i desideri e i conflitti rimossi.
L’Obiettivo: “Wo Es war, soll Ich werden”(“Dove era l’Es, deve subentrare l’Io”). La liberazione è sostituire la coazione inconscia con la scelta (per quanto limitata) dell’Io.
10. L’Esistenzialismo: La Libertà al Centro
Con Heidegger e Sartre, la libertà non è più solo un *problema* filosofico, ma diventa l’essenza stessa dell’esistenza umana.
L’uomo è l’unico ente il cui modo di essere è l’interrogarsi sul proprio essere, e quindi… scegliere.
Heidegger: La Prigione dell’Esistenza Inautentica
L’uomo è *Dasein* (Esser-ci), un essere “gettato nel mondo” senza averlo chiesto.
La prigione è l’esistenza inautentica: la fuga dalla nostra unicità per rifugiarci nell’anonimato del “Si” (das Man).
- Si dice, si fa, si pensa…
- È la vita dominata dalla “chiacchiera”, dalla “curiosità” e dall'”equivoco”.
Heidegger: La Rivelazione dell’Angoscia
Come ci si libera? La via è annunciata da un’emozione fondamentale: l’Angoscia (*Angst*).
L’Angoscia non è “paura” (che è sempre *di qualcosa*), ma è l’angoscia *del nulla*. Ci fa sentire spaesati e ci rivela la nostra vera condizione.
L’Angoscia ci mette di fronte alla nostra “possibilità più propria”: l’essere-per-la-morte.
Heidegger: La Liberazione come Esistenza Autentica
L’uomo non è una cosa fissa, ma è “poter-essere” (possibilità).
La liberazione è l’esistenza autentica. Consiste nell'”anticipazione della morte”: vivere sapendo di dover morire ci libera dalla banalità e ci costringe a scegliere.
La libertà autentica è assumersi la responsabilità del proprio, unico progetto di vita.
11. Sartre: “L’Esistenza Precede l’Essenza”
Sartre porta l’esistenzialismo alle sue estreme conseguenze.
Prima esistiamo (“gettati nel mondo”), e solo *dopo*, attraverso le nostre scelte, definiamo chi siamo (la nostra “essenza”).
Non c’è una natura umana, non c’è un Dio che ci ha progettati. Siamo radicalmente liberi.
Sartre: La Prigione della “Malafede”
Questa libertà assoluta è terrificante. Genera Angoscia.
La prigione è la “malafede” (*mauvaise foi*): è la fuga dalla libertà. È il mentire a noi stessi, pretendendo di *dover* essere in un certo modo (un cameriere, un professore, un “bravo ragazzo”), come se fossimo una cosa (un *essere-in-sé*) e non una pura possibilità (*essere-per-sé*).
Sartre: La Prigione dello Sguardo Altrui
La nostra libertà è minacciata anche dallo sguardo dell’Altro.
Lo sguardo altrui ci “reifica”, ci trasforma in un oggetto, ci definisce. Ci ruba le nostre possibilità e ci giudica. È in questo senso che va intesa la famosa frase:
“L’inferno sono gli altri.”
Sartre: La Liberazione come “Condanna”
Per Sartre, non c’è una vera “liberazione”, perché siamo già liberi. Non possiamo non esserlo.
“L’uomo è condannato ad essere libero. Condannato perché non si è creato da se stesso, e pur tuttavia libero, perché, una volta gettato nel mondo, è responsabile di tutto ciò che fa.”
La “liberazione” consiste solo nell’accettare questa condanna e nell’assumersi la responsabilità totale di ogni nostra scelta.
12. Wittgenstein: L’Ultima Prigione
Il percorso del ‘900 si conclude con una prigione inaspettata: non la morale, non l’inconscio, ma il linguaggio stesso.
Molti dei nostri grandi problemi (cos’è l’Essere? cos’è la Volontà? cos’è la Libertà?) non sono problemi reali, ma “crampi mentali”.
Sono malattie causate da un uso scorretto del linguaggio, che ci intrappola in “giochi” che non comprendiamo.
Wittgenstein: La Liberazione come Chiarezza
Il percorso di liberazione è la filosofia intesa come terapia.
Il suo scopo è “mostrare alla mosca la via d’uscita dalla bottiglia”.
La libertà non è trovare la risposta, ma *dissolvere la domanda*. È la chiarezza: comprendere come funziona il nostro linguaggio e quali sono i suoi limiti.
“Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere.”
Conclusione: Il Filo Rosso (Antichità)
Il percorso di “liberazione” ci ha portati a fuggire:
- Dall’Ignoranza di noi stessi (Socrate)
- Dagli Estremi e dagli impulsi (Aristotele)
- Dalla Paura della morte e degli dèi (Epicuro)
- Dal Peccato come cattivo uso del volere (Tommaso)
- Dai Dogmi e dai limiti del pensiero (Bruno)
Conclusione: Il Filo Rosso (Modernità)
Il viaggio moderno ci ha portati a liberarci:
- Dall’Eteronomia e dalle passioni (Kant)
- Dalla Volontà di Vivere cosmica (Schopenhauer)
- Dalla Morale del risentimento (Nietzsche)
- Dall’Inconscio e dal senso di colpa (Freud)
Conclusione: Il Filo Rosso (Contemporaneità)
Infine, il ‘900 ci ha chiesto di liberarci:
- Dalla Banalità dell’esistenza inautentica (Heidegger)
- Dalla “Malafede” che nega la nostra libertà (Sartre)
- Dalle Trappole del Linguaggio (Wittgenstein)
La Libertà Oggi
Il viaggio della filosofia ci mostra che la libertà non è mai un traguardo raggiunto una volta per tutte, ma una conquista e una responsabilità costanti.
La domanda finale che resta aperta è:
Quali sono le nostre prigioni contemporanee? E quali i nostri percorsi di liberazione?
Grazie per l’attenzione.